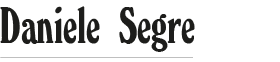a cura di Marco Bertozzi, L’idea documentaria, Lindau, 2000, Torino.
In questi 20 anni hai attraversato un orizzonte espressivo che ha posto il cinema della realtà come centro della tua esperienza…
Il primo film lo realizzai nell'inverno del 1975, quindi sono più o meno 27 anni che vivo di questo mestiere. Devo dire che è stato un naturale approdo, sia per la mia formazione di fotografo sia, semplicemente, per opportunità di tipo economico: in questo campo non mi sarei potuto permettere di fare altro se non lavorare all’interno di quella grande miniera che è la realtà. Grazie a essa, ho potuto sviluppare o mettere a fuoco urgenze espressive che mi hanno poi portato al confine con la “non realtà”. Quindi la realtà è divenuta strumento attraverso il quale definire sempre meglio una ricerca personale.
Vuoi dire che è stato anche un elemento contingente, il fatto che era più semplice, più vicino a te lavorare all’interno di territori realistico-documentali…
.
No, non più semplice, forse più vicino, certamente non più facile: non potrei permettermi di immaginare senza fare, ho bisogno di fare. Realisticamente, è stato quello che mi consentiva di poter sviluppare una ricerca personale, una ricerca di linguaggi. Con la finzione non ero in grado di farlo, essenzialmente per motivi economici. Poi ho preso consapevolezza dell’importanza di essere indipendente. Quindi necessità, ma anche opportunità all’interno di una strategia di ricerca che, ovviamente, partiva da un sano realismo.
Mi sembra importante che tu parli di ricerca,perché spesso usando la parola documentario, la si relega ad un ruolo meramente riproduttivo, nell’accezione più banale del termine. Per me, lo sai, l’idea documentaria è invece luogo di sperimentazione linguistica, di lotta fra supposta “realtà” garantita dal dispositivo e processi di messa in forma…
Non provengo da una formazione scolastica di studi cinematografici, quindi non mi ero mai confrontato con i linguaggi del cinema. Non sono mai stato un cinefilo, quindi non ho avuto modelli che potevano condizionarmi. La mia è stata una necessità espressiva forte, una specie di urgenza, ma senza condizionamenti, nel pieno rispetto della mia integrità. A forme e linguaggi di grandi autori mi sono avvicinato dopo, ormai certo di ciò che ero diventato, proprio per evitare contaminazioni pericolose, che avrebbero potuto, in qualche modo, condizionarmi. Non potevo permettermelo, proprio per l’ambizione di ricercare la mia unicità (che è poi la molla che hanno tutti quelli che cercano di diventare autori).
Ma c’é stata una tua evoluzione nel mettere in forma la realtà? Ad esempio tra Vite di ballatoio (1984) e Paréven furmighi (1998) mi sembra ci siano notevoli differenze. Riusciresti a definire questo mutamento di poetica?
I lavori che hai citato sono significativi, rappresentano momenti precisi della mia ricerca. Vite di ballatoio è un documentario estremamente contaminato, ci sono segnali che a distanza di vent’anni ho recuperato diventando autore teatrale: in un certo senso, è come se l’avessi fatto ieri, proprio per le tecniche di lavoro sulla messa in scena, partendo dalla cosiddetta “realtà della vita”. Parevan furmighi coniuga invece bisogni analoghi con un linguaggio diverso, e si inserisce in quel filone nato nel 1991 con la realizzazione di Partitura per volti e voci — Viaggio tra i delegati CGIL (1991), percorso poi sviluppato con una serie di film che definirei “serialità della realtà”. Si tratta di opere attraverso le quali ho portato la serialità in ambienti-studios diversi, dalla camera d'albergo a un cinema. In questi luoghi (anche per motivi produttivi, perché unificarli mi permetteva di abbattere i tempi di lavoro e quindi di risparmiare) sono stato costretto a fare evolvere il mio linguaggio. Sembra un paradosso, ma negli ultimi 10-12 anni il mio “cinema della realtà” si è espropriato sempre più della realtà; o, meglio, la realtà è stata trasportata in luoghi di finzione, manipolando la luce e la scenografia, ma mantenendo inalterata la qualità del vero attraverso i personaggi “messi in scena»”.
Spesso chi fa documentari viene accusato di modificare la realtà, per la presenza della camera. Chi pone questa obiezione é all’interno di un paradigma al tempo stesso “ingenuio” e “scientifico” e non si rende conto che chiunque, anche nei processi di autorappresentazione, chi “recita” racconta di sé. Si tratta solo di ammettere di lavorare su un livello più profondo della realtà, che forse è inscindibile i irrappresentabile…
La questione del recitare è un confine molto delicato, che deve essere gestito con grande attenzione, perché il rischio è che questa “recitazione” alla fine si riveli finta (con un risultato “finto-finto”): mentre a me interessa il “vero” collocato dentro una struttura “finta”, ma che riesca ad avere più forza ancora del “vero più vero”. Specifico questo perché è un processo fondamentale per il lavoro sulla realtà, proprio in questo tempo mediatico in cui l’esistenza sembra data solo da una pseudorealistica visibilità televisiva. Questa è una delle chiavi dell’identità della mia ricerca espressiva: il lavoro che faccio sulle persone cerca, nel limiti del possibile, di evilare questa condizione, anche se questa complicata integrazione fra il vero e il finto corre il rischio di crollare se la relazione non è gestita in un certo modo. Certo, i protagonisti di un documentario “recitano”, ma tutti quanti recitiamo; il problema è stabilire qual è il grado di consapevolezza che il personaggio/protagonista ha nel mettersi in scena (non per la macchina da presa, ma per il motivo per cui tu lo hai chiamato). È una questione di determinazione e di fiducia che lui dà al regista: in un certo senso è come se si “donasse” per farsi manipolare, ma questo manipolare deve essere messo fra quattro virgolette, perché coinvolge il livello di coscienza di ciò che si sta facendo.
Parli di coscienza, di consapevolezza, sia dalla parte di chi “recita” che dalla parte del regista. Ora, può esserci un livello di non consapevolezza dei soggetti ripresi, che, in qualche modo, può però essere utile al regista ..
Si, puo accadere, specialmente nel momento in cui certe cose nascono all’improvviso e non hanno le caratteristiche di una reale messa in scena. Allora devi riuscire a trovare e a decodificare i linguaggi della realtà, individuare l’essenziale e non farti premiere dalla globalità delle cose che succedono: tu sei un chirurgo, che deve avere un alto quoziente di lucidità per decodificare i segnali che ti arrivano in continuazione, in tempo reale, ed essere in grado di individuare quello che è necessario. È come se dovessi chiederti in continuazione: “Cosa sono venuto a fare io qua?» e “Cosa devo raccontare? Come lo devo raccontare?». Di conseguenza l’analisi, lo screening che dovrebbe definire il plot, il trattamento e la sceneggiatura in corso d'opera, sono frutto di una continua elaborazione di dati, sino a trovare un centro della ricerca, su cui costruire un impianto strutturale del racconto. Non è casuale la realtà, anche se si manifesta a1l'improvviso, non è casuale lo sguardo che tu vuoi offrire alla realtà, nel senso che è filtrato dalla tua sensibilità, dalla tua poetica, dal bisogno urgente che ti ha portato in quel luogo e non in un altro. Per me è sempre stato così; la decisione di partire, almeno per quattro o cinque film, è stata immediata. In questo momento stiamo parlando e non so cosa farò fra 10 mmuti. Se dovesse arrivare un segnale esterno, improvviso, che per vari motivi potesse produrre strane alchimie, potrei partire subito. Così è stato per alcuni dei miei film: una notizia letta su un giornale o sentita in televisione, e in un minuto ho deciso: “Parto e vado a fare il film”. In corso d’opera ho poi istruito la pratica, con un autocontrollo delle emozioni da chirurgo di fronte a una operazione a cuore aperto.
Allora il titolo del tuo intervento potrebbe essere “Le decisioni del chirurgo” o “IL viaggio del chirurgo”?
Un regista è una persona che ha grandi responsabilità, nel senso che deve fare un intervento. Sono consapevole dei rischi a cui vado incontro, ma sono anche consapevole del ruolo che vivo in questa società; certo, a volte ho fatto delle operazioni per alcuni incaute, ma necessarie per me. Un regista deve decidere se intervenire o non intervenire. Non intervenire significa non guardare, non decidere, quindi appiattirsi sullo sguardo dominante. Perché se vai a raccontare la vita di un formicaio non hai problemi, mentre se vai a riprendere una situazione drammatica come la chiusura di un giornale, del più grande giornale della sinistra, e metti a nudo i limiti e le contraddizioni di quella parte politica, è chiaro che metti in gioco anche il tuo futuro professionale. Ma questo è il ruolo che deve giocare un regista nella società, cioè intervenire: fa parte del gioco di un intellettuale “organico”, sentirsi a posto con la propria coscienza, nel mondo.
Il mio può essere un cinema sentimentale-melanconico, ma quando è necessario diventa molto ruvido, un pugno nello stomaco che può toglierti il fiato. Questa è la vita, e vale ancora più del cinema: la possibilità di essere indipendente -anche se non sempre è vero, sarei presuntuoso a dirlo, non sempre ti può capitare questo privilegio e non può essere una regola, non lo è neanche per me -è il privilegio più grande che può capitare a un uomo che desidera esprimersi. Da questo punto di vista, malgrado la complessità del lavoro mi sento un privilegiato, un fortunato (anche se devo gestire un senso dell’inquietudine che credo simile a quello di coloro che vogliono esprimersi). Insomma, credo a un cinema a 360°, credo che sarei anche in grado di fare un colossal, non avrei problemi, ma ho bisogno di partire e di andare verso un ignoto, qualcosa che, pur se valutato e filtrato, genera l’idea del cinema come viaggio. E io sono sempre pronto a partire.
Mi viene in mente Manila Paloma Blanca, il viaggio interiore dell’attore protagonista…
Manila è stata una tappa fondamentale, anche rispetto alla verifica di linguaggi diversi. È stata un’esperienza unica, come Vecchie (2002), pur nell’estrema inquietudine di una scelta impegnativa. La voglia della ricerca ti costringe a non accontentarti delle forme e dei linguaggi, ti fa alzare il tiro della verifica. L’approdo a ciò che ho definito “serialità della realtà” non l’ho studiato da nessuna parte, l’ho vissuto sulla mia persona, sia come regista sia come produttore: come regista avevo bisogno di grandi contaminazioni, come produttore avevo pochissimi soldi per fare quei lavori, e quindi ho cercato di coniugare il bisogno e l’arte. È stata una cosa molto pratica, come un falegname che deve costruire una libreria.
NelI’idea di grande artigianato italiano?
Assolutamente sì, laddove l’espressione è vitale, mai scontata, e ogni passo una scoperta sensazionale. Pensa alle figure professionali, prendi il direttore della fotografia, che nella tradizione del cinema della realtà serve e non serve, basterebbe un bravo operatore. A un certo punto ho avuto l’esigenza di un direttore di fotografia che provenisse dall’altra parte del cinema, da un cinema di finzione che più di finzione non poteva essere, proprio per suggerirmi stimoli cromatici e luministici, per manipolare o proporre interventi capaci di valorizzare anche il cinema della realtà e di ricerca. Non ho fatto un salto di campo, ma ho cercato di trovare e continuo a cercare di trovare degli approdi non banali…
Quest’ipotesi di ricerca ha avuto recentemente un approdo clamoroso, nel senso che sette mesi fa giravo un film, Vecchie, che poco dopo è diventato spettacolo teatrale e poi è andato anche in radio. Quindi, nel giro di pochissimo tempo si è creata una dimensione multimediale, qualcosa di incredibile perché otto mesi fa non esisteva neanche il copione, qualcosa di unico e, sinceramente, molto stimolante. Forse siamo anche stati molto fortunati, perché si sono verificate delle condizioni fortuite che hanno permesso di accelerare i tempi per mutuare le forme e i linguaggi della
rappresentazione.
Ma in che modo c’è ancora un orizzonte documentario in un lavoro come “Vecchie”?
Forse ho capitalizzate i 30 anni della mia ricerca in un investimento prospettico che aveva già come prima necessita l’approdo alla finzione. Sono riuscito a rielaborare una serie di capacità e di esperienze vissute nello studio della realtà; con una complicazione non secondaria, che Vecchie nasce come esigenza terapeutica per liberarmi dall’angoscia di un film che avevo fatto e dal quale, per motivi personali, non riuscivo a uscire (forse perché era state fonte di una grandissima e grave delusione). In qualche mode ho avuto conferma di ciò che dico spesso ai miei studenti: che il cinema lo faccio innanzitutto per me e pei per gli altri. In fondo, Vecchie nasce con l’esigenza di liberarmi di un’angoscia che mi faceva deperire, che annullava il mio desiderio di fare un certo tipo di cinema.
Puoi dirci qual è stata la fonte di questa angoscia?
I film che ho fatto sulla chiusura de “L’Unita” (Via Due Macelli, Italia. Sinistra senza unità – 2002), un film brutto per i contenuti e brutto per l’umanità che ho raccontato: una grandissima delusione perché non mi aspettavo situazioni così penose…
Per quello che hai documentato o per la storia del film in sé?
Per quello che racconta il film, la fine di un momento, l’idea che io avevo della sinistra; con quel film ho visto come era ridotta e sono stato malissimo. L’ho dovuto fare, ormai c’ero dentro, ma non mi aspettavo che avrebbe avuto quell’epilogo. In fondo, io ero andato lì per raccontare un giornale che chiudeva, ma non mi ero reso conto pienamente che andavo a “L’Unità”. Nel momento in cui mi ci sono trovato dentro, ho veramente vissuto un brutto viaggio: mi sono dovuto confrontare con un’idea andata in crisi, anche per colpa di uomini che non sono stati in grado, malgrado l’ampia delega avuta, di realizzare un vero cambiamento. Grazie al cinema sono riuscito a liberarmi di quest’angoscia: in fonde Vecchie (già sul titolo potremmo farci un saggio) racconta di due donne anziane chiuse in una casa, dalla quale, per motivi diversi, non vogliono uscire e continuano a bisticciare. È come se mi fossi completamente liberato, ritrovando una serenità perduta per colpa di quel film precedente; film necessario, ma, forse, per il mio benessere psicologico, avrei potuto risparmiarmelo. Quindi, in questo caso, oltre al problema dei linguaggi, della loro contaminazione, c’e anche il discorso della terapia e della conoscenza. Ogni film è un pezzo di me che si racconta, in
ogni mia opera ci sono io che, grazie al film, riesco a trovare il senso della mia inquietudine. In fondo, con Vecchie avevo bisogno di liberarmi di un’angoscia: solo che non potevo fare un film sulla realtà, l’avevo già fatto. Probabilmente dovevo liberarmi di quella realtà che mi stava opprimendo, e ho usato la finzione per liberarmene. Vedi… è contorto, però tutto torna, anche rispetto alla mia identità di autore… È la verità, ti ho detto assolutamente la verità. Così, pubblicamente, non l’avevo ancora detta.